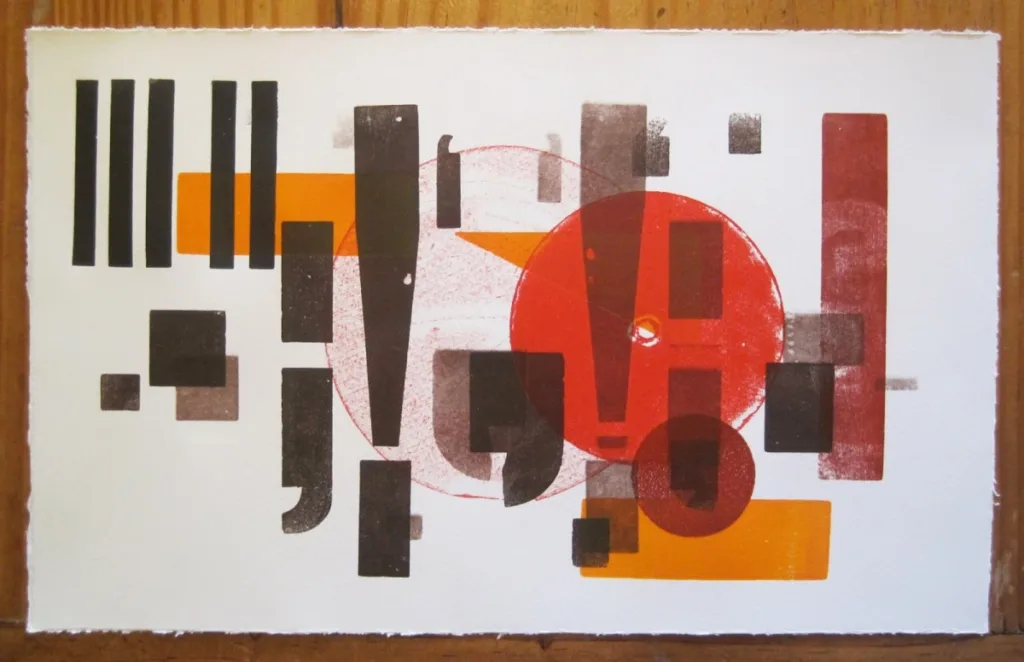
In un brevissimo racconto di Cechov, intitolato “Il punto esclamativo” un diligente funzionario con ruolo segretariale trascorre una notte inquieta, ragionando tra veglia e sonno sulla consapevolezza con cui ha distribuito la punteggiatura nel suo ormai quarantennale disbrigo burocratico. Passa in rivista le sue truppe di interpunzione, traendone la rassicurante certezza di averle apposte sempre con cognizione di causa. Fino a che gli si para davanti come un bravaccio quello spilungone con il masso pendente sul capo. Il buon Peredlakin si agita, si rigira, sì, forse l’ha incrociato ma che il diavolo se lo porti (il punto interrogativo) se mai l’ha deposto sulla carta col suo inchiostro. Sveglia la moglie che gli è sdraiata accanto. Lo sa lei perché si mette il punto esclamativo? Ma certo (o forse: ma certo!). Per esprimere entusiasmo, sdegno, gioia, collera ed altri sentimenti. Peredlakin è schiacciato dall’angoscia. Possibile che nelle carte da lui vergate abbia sempre espunto i sentimenti? Può darsi che il punto esclamativo attendesse da tempo la resa dei conti, perché il brav’uomo, che chiuda gli occhi o li spalanchi, non riesce più a scacciarne la fisionomia, e se lo ritrova sugli stivali, nel servizio da tè, davanti allo specchio di casa che lo flagella imputandogli di essere un pezzo di legno insensibile. Una volta giunto in ufficio lo riconosce nel pennino stesso. Presolo in mano, fa seguire alla sua firma tre punti esclamativi. E quel bellimbusto finalmente si pacifica e scompare.
Aveva avuto torto Peredlakin ad attendere quarant’anni? In teoria no perché, come scrisse il linguista Giacomo Devoto, si tratta di un segno “affettivo” da contrapporre a quelli intellettuali, e quando c’è da esprimere oggettività bisognerebbe lasciarlo da parte. Del resto vi siete mai imbattuti in un punto esclamativo sulla Gazzetta Ufficiale? E però, a pensarci: sarà stata davvero una buona tradizione estrometterlo dalla scrittura legislativa? O quella debolezza dell’afflato affettivo che fascia le norme sarà una una concausa per la disaffezione che con il tempo finisce per infiacchirne la presa morale sui cittadini? Come per vendetta grammaticale, tanti discorsi sulle leggi sono presidiati dal suo lavico eruttare (bisognerebbe buttare la chiave! Ridurre il cuneo fiscale! Aumentare le pensioni! Reintrodurre l’aborto! Parificare le unioni ai matrimoni!). Un’ipotesi rivoluzionaria di riforma dei lavori parlamentari potrebbe consistere nell’obbligo di non cambiare capoverso se prima non si è passati per un punto interrogativo. Ma questa asimmetria tra legislatori e pubblica opinione si ripete tra i giudici che scrivono le sentenze e i giuristi che le criticano sulle riviste: anche se una maggiore disinibizione espressiva comincia a circolare nella scrittura di qualche magistrato più vivace, toccherà poi alla glossa del commentatore riprendere il passo letterale di una sentenza per aggiungere al suo interno l’interpunzione (!), il punto interrogativo dentro la parentesi, la massima berlina retorico-grammaticale. Come dire: io non mi disturbo neppure a contrapporre qui una mia argomentazione. Riporto la frase perché da sola grida scandalo, suscita ilarità, pascola nei campi del grottesco. Lo capite da soli, no, che cazzata hanno scritto?

Sospetto di muscolare aggressività il punto esclamativo, pertanto, viene bollato di immaturità da stroncare per esigenze pedagogiche. Il Ministero dell’Educazione britannico, nel 2016, emanò un’apposita direttiva rivolta al personale insegnante, chiamato a stigmatizzare da parte degli studenti gli usi non fisiologici del P.E., cioè quelli che esulano dal chiosare una esclamazione idiomatica (santo cielo! Che stupido!). E intanto fioccavano gli articoli che lamentavano il rischio di un’emorragia di puntesclamativite a causa dei social. I ragazzi, i ragazzi! Riempiono i messaggi più di punti esclamativi che di parole! E per forza! eccepiva la giornalista del New York Times, Madeleine Aggeler. Se uno vi propone di vederci e invece di rispondere “okay!” ti limiti a “okay”, si tratta dell’equivalente di “perché non ti trascini in una caverna e muori?”. In sostanza, lo scambio digitale è spoglio e freddo se non lo colori di partecipazione emotiva. E quale miglior animatore del punto esclamativo, meglio ancora se due o tre? Si potrebbe obiettare che per sua natura il punto esclamativo è minaccioso, e lo dimostrerebbe la segnaletica stradale che se ne serve per avvertire di un pericolo o quella degli imballaggi che (capovolgendolo) evidenzia la fragilità del materiale. Ma secondo la linguista Gretchen McCullock quei tempi sono finiti. Ormai il punto esclamativo, specie se lo si infila in un festoso bailamme di lettere maiuscole, corrisponde a un sorriso sociale. Via libera dunque alla prevista frana di punti esclamativi, specie nella conversazione giovanile. Ebbene, constato che c’è un certo ritardo nel rilevarlo: ma la previsione si è rivelata clamorosamente sbagliata.

Se parliamo di post rivolti a un pubblico il punto esclamativo tira ancora, perché alza la temperatura emotiva. Si spiegano così, oltre che con l’analfabetismo e i disturbi della personalità, i record polverizzati da Trump che nei 53.000 tweet pubblicati in 12 anni, tra il 2009 e il 2020, ha infilato 33.000 punti esclamativi, una volta quindici di fila (per commentare che l’oscar per il miglior film non fosse andato a una produzione americana). E si comprende perché, nell’esame di 6000 post pubblicitari di brand del 2021, quelli che contenevano un punto esclamativo abbiano registrato un terzo in più di accessi. Nei messaggi è differente: torniamo alla moglie di Peredlakin: il punto esclamativo si usa per manifestare sdegno, gioia, collera, altri sentimenti…ma amici, questo è una banderuola (punto esclamativo). Lo scrittore francese Hervè Bazin ne propose persino tre varianti grafiche a seconda della sua finalità, con stilizzazioni di dubbio gusto che in un test di Rorschach potrebbero richiamare le carote (una scelta pacifista in luogo del bastone?), una croce e un’ala destra lanciata verso la porta avversaria . Come fai a fondarci davvero una conversazione a distanza senza temere l’equivoco? Se la sarà presa o ne è stato felice? E quanto ne è stato felice? Giustamente i più giovani hanno scoperto che gli emoticon risolvono ogni dubbio. Con il punto esclamativo ci si arrangia fino a che non c’è di meglio, e a lungo (fino a tutti gli anni sessanta) non c’era neppure lui, non almeno su molti modelli di macchina da scrivere, per cui si doveva aggiungere a penna, oppure surrogare con apostrofo/backspace/punto. Gli emoticon sono in fondo sottocategorie del punto esclamativo, sue declinazioni. Io ne ho un certo pudore ma è un problema mio (ed è un problema relativo perché non comunico per messaggistica ma per mail), né mi spingono all’emulazione i coetanei che per ipercorrettismo e pseudo-giovanilismo li rovesciano come se stessero sgrullando la tovaglia. Ma ne riconosco il valore espressivo, salvo che, come per i punti esclamativi, una certa parsimonia ne tutela la qualità di attenzione partecipata piuttosto che di reazione elettrica a uno stimolo.
E cosa farne nella scrittura letteraria? Mark Twain, e a distanza di cinquant’anni Scott Fitzgerald, li liquidarono con sprezzo: è come ridere delle proprie battute. Si vede che avevano in mente un certo tipo di uso, quello del paradosso. Non si può dire che i grandi scrittori americani abbiano adottato una linea uniforme: all’unico punto esclamativo di Hemingway in tutto Il vecchio e il mare si contrappongono i 1863 che Melville disseminò in Moby Dick, e c’è da sorprendersi che la balena non vi sia rimasta uncinata. In Italia, Ugo Ojetti scagliò un anatema contro quel “pennacchio su una testa tanto piccola, questa spada di Damocle sospesa su una pulce, questo palo per impalare il buon senso, questo stuzzicadenti pel trastullo delle bocche vuote”. Negli Stati Uniti un severo editor suggerisce di lesinarne due ogni centomila parole.

Come minimo, però, bisogna differenziare tra il testo in prima persona e il dialogo, perché è di dubbia etica che lo scrittore possa privare i suoi personaggi della marca d’intonazione e del risvolto psicologico che sulla carta prendono la forma del punto esclamativo. Tolstoj e Dostoevskij si sarebbero fatti una risata se un editore avesse proposto di purgare Guerra e pace e I fratelli Karamazov dalla messa in bocca (o piuttosto, fuori dalla) di pennacchi sulla testa tanto piccola ai protagonisti. Ovviamente, ognuno opera secondo la propria sensibilità; Italo Calvino non si fa problemi, ne Il cavaliere inesistente, nel far dire a Carlomagno: “Cavalier Agilulfo! Sapete cosa vi dico? Vi assegno quell’uomo lì come scudiero!” cinque righe sotto il rimprovero di Argilulfo a Gurdulù che buttava cucchiaiate di zucca nel tronco di un albero: “Non è la tua bocca quella! È dell’albero!”. A Ignazio Silone era praticamente impossibile estorcene uno pure nei dialoghi, mentre lo Zeno di Svevo in prima persona ne spara senza ritegno nei suoi monologhi interiori. Molto dipende dall’impostazione tematica del romanzo: sarebbe stato ben strano trovare dei punti esclamativi ne La Noia di Moravia. Altra ragione di soppressione è l’adozione di uno stile che elide la punteggiatura tradizionale dei dialoghi, sostituendola con dei puri a capo che quasi vanno a costituire un impasto con i passaggi di narrazione oggettiva, come ad esempio ne La simmetria dei desideri di Nevo o ne La promessa di Galgut.
Come tante altre cose, il punto esclamativo nacque nei monasteri medievali, dove gli amanuensi che ricopiavano testi del passato- quando volevano sottolineare entusiasmo per il passo- aggiungevano la parola “io” che stava per “evviva”. Poi, vai a sapere se per stravaganza, moda o tremore delle mani, la i si allungò e la o si spostò in alto. Il poeta trecentesco Iacopo Alpoleio da Urbisaglia, tuttavia, nell’inserirlo fra i segni di interpunzione nel trattato De ratione punctandi sostenne di averlo inventato lui. Ma il primo usarlo in concreto pare sia stato il letterato e Cancelliere di Firenze tra il 1375 e il 1406, Coluccio Salutati (insomma, proprio nei dintorni della politica venne sperimentato: ripensate a quel che dicevo all’inizio sulle leggi…)
Il punto esclamativo ha conservato la sua indipendenza resistendo a ogni tentativo di fusione societaria; il progetto di formalizzare l’interrobang, la sua sovrapposizione con quello interrogativo quando lo stupore è particolarmente straniante (capita sovente nei fumetti che si seguano l’un l’altro) non è decollato.
Al tirar delle somme riguardo alle mail o le lettere, per quei pochi, che ancora ne scrivono, come regolarsi? Varrà quel che la scrittrice Meg Wolitzer pensa riguardo alla letteratura, e cioè che se si ricorre al punto interrogativo significa che la frase non ha funzionato? Non sarei così radicale. Vero è che ci sono modi più eleganti di assolvere la funzione, tipo l’eclettico ed emergente corsivo. Vero è che se vuole evidenziare un concetto, tratta da stupido quello che legge (beninteso, in certi casi questa sarebbe una giustificazione). Come veicolo di ironia conserva un certo fascino (metto in esclamativo un’affermazione che dovrebbe essere normale: quindi rincasi stasera!); e sempre come artificio retorico dell’ironia nella comunicazione a una burocrazia è ottimo per far saltare il banco (e il burocrate della sedia! Sì, caro Peredlakin. Mi spiace ma è così). Ritornando alla questione affettiva rimane un’alternativa per chi è refrattario agli emoticon, che del resto non sempre sono appropriati in assenza di familiarità. A me qualche volta non dispiace al posto del caro, davanti al nome, all’inizio di una mail, specialmente in risposta, come scherzoso cameratismo. L’ultima questione è: ne vanno bene un po’ di fila? In una conversazione spiritosa fanno allegria, tipo il bicchiere della staffa. Ma nella normalità, mi viene in mente la perla di saggezza di un investitore di media: ogni volta che metteva un punto esclamativo tornava indietro per cancellare quelli precedenti, definendo ciò “una specie di scelta di Sophie”.
Corrado Augias, Il Venerdì
Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore
La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio
Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:
-
Hai detto male di me
-
Hai violato un confine
-
Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto


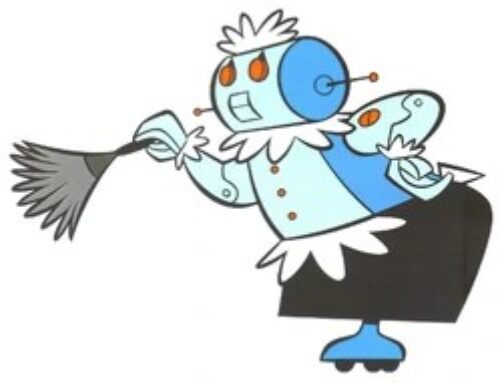


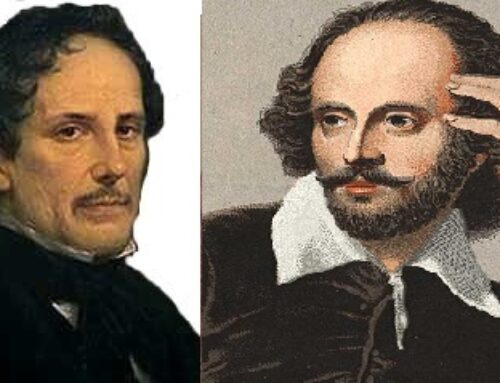

Scrivi un commento