
Rispetto alla Biennale del 2017 l’avanzamento è palpabile, rispetto a quella del 2015 la differenza abissale: l’arte si è rituffata verso l’impegno sociale e la militanza ideologica (in senso nobile), senza nulla perdere in spontaneità ma anzi offrendole un punto d’appoggio. È un impegno indirizzato verso alcuni temi canonici: fra tutti la sensibilizzazione ecologista e la critica dell’oppressione di genere o di razza o il colonialismo, culturale e non (l’attenzione verso il classismo invece langue alquanto), il disordine mediatico. Quel che è certo è che il tema dell’io disgregato, che ha quasi monopolizzato per una ventina d’anni il campo dell’arte, scorre ora lateralmente, restituendo alla focalizzazione sulla responsabilità collettiva il cuore dell’attenzione. La curatela ha messo il suo nel favorire quest’inclinazione scegliendo il tema: “May you live in interesting times”, citazione di una (probabilmente finta) maledizione cinese – “che tu possa vivere in tempi interessanti” – da parte di sir Austin Chamberlein in una seduta del Parlamento inglese, nel 1936, per stigmatizzare il pericolo rappresentato dall’ingresso delle truppe tedesche in Renania.

Khyentse Norbu
Quali sono le altre relative costanti dell’arte in esposizione alla Biennale? Ne indicherei quattro.
- Una certa predilezione per la distopia all’interno dei canoni narrativi veicolati dalle opere.
- Un incremento della parte acustica all’interno delle installazioni: quasi un’appendice che si avvia a diventare obbligatoria, e in alcuni casi il centro gravitazionale.
- La messa in scena della contaminazione, che un po’ come accade per la pittura nell’espressionismo astratto non rimane nascosta quale elemento formale di costruzione ma è l’oggetto stesso dell’opera. Abbondano ostentate e narrate sovrapposizioni, traduzioni, trascrizioni (due esempi didascalici ma legati a dei video: il padiglione dell’Australia si affida a un video nel quale assistiamo alla scrittura di un testo poetico prima di vederlo trasmutato nel linguaggio musicale o nel linguaggio dei segni; nel padiglione canadese un video sugli inuit trova il suo punto di forza nell’attività di un traduttore che non riesce a spezzare – e nemmeno ne ha intimamente la volontà – il divario interiore e culturale degli scambi di comunicazione tra un inuit che non vuole abbandonare la sua terra espropriatagli e un colonizzatore che cerca di convincerlo ad entrare in un insediamento di nuova costruzione). Più genericamente, la contaminazione è di materiali, generi, realismo e finzione.
- La crescente marginalità delle opere da parete. La poca presenza della fotografia (segnalo però gli splendidi lavori di Rula Halawani sui territori occupati; gli autoritratti perturbanti di Zanele Muholi; gli assemblaggi filosofici e zen di Khyentse Norbu ) è una genuflessione verso la sua condanna in termini di redditività da parte del mercato; la pittura invece continua a rotolarsi nella crisi profonda dei suoi linguaggi storici (personalmente ho trovato significative solo le opere esposte nel Padiglione del Sudafrica). Al contrario, la massa volumetrica trova nuove formule originali sia nelle numerose sospensioni sia nell’instillazione di equivoci sulla consistenza del materiale (cito per tutti Carol Bove, che conferisce alle sue massicce sculture forme apparentemente e falsamente cedevoli, grinzose, svolazzanti, enfatizzate dai colori accesi).

Carol Bove
L’idea di suddividere le opere di ciascuno degli ottanta artisti invitati, al di fuori dei Padiglioni nazionali, tra l’Arsenale e i Giardini, invitandoli a mostrare segni di discontinuità nella propria creazione, era intrigante, ma in realtà il meglio si concentra quasi tutto all’Arsenale.
Provo a raccontare giusto quattro tra le esposizioni che ho trovato più coinvolgenti.
Non è per forza un male che un’opera si possa apprezzare fino in fondo solo leggendone la spiegazione: è il caso dell’indiano Shilpa Gupta che accosta in uno spazio che si può percorrere cento microfoni appesi sotto i quali sono collocati altrettanti supporti appuntiti su cui è infilzato un foglio di carta con dei versi, mentre dai microfoni escono voci recitanti sovrapposte. Si tratta delle voci di cento poeti della storia che si sono scontrati con l’autorità e da quella sono stati incarcerati e uccisi. Una volta letta la storia è difficile scollarsene. Bisogna però riconoscere che Boltanski, ad esempio, riesce a commuovere secondo canovacci analoghi ma meno eroici, senza che sia necessario alcun aiuto introduttivo.
Similmente, Teresa Margolles ha la splendida idea di riallestire uno spazio plausibilmente reale, tre pannelli di vetro tipici delle stazioni metro con affisse pagine di giornali riguardanti donne uccise o scomparse nel Messico, pannelli che vibrano alla riproduzione in bassa frequenza dei rumori dei treni. La trasfigurazione però è puramente sentimentale ed emotiva. Con una piccola manipolazione ci sembra commovente quel che avremmo trascurato o scansato dal vivo. Ma non ci commuove perché è bello. È bello perché ci commuove.
Per rifugiarsi in un’estetica squisita seppur non consolatoria, nella quale il bello è l’adescamento per la riflessione sociale, dobbiamo allora rivolgerci alle sorelle Wertheim che attraverso migliaia di collaborazioni ricreano forme botaniche e coralline all’uncinetto, legando poi la lana a fili, cavi elettrici, nastri di videocassette e perline. Dentro queste sorprendenti e poetiche merlettature troviamo un’infinità di rimandi: la corrosione del tempo, gli accumuli tossici, la cooperazione umana disinteressata e la sua possibilità di ricreare la natura.

Tomàs Saraceno
Fuori dall’Arsenale, sulla laguna, Tomas Saraceno – diventato famoso per avere trasformato quasi sinfonicamente attraverso l’amplificazione il suono prodotto dalle ragnatele – espone un’installazione che produce un suono ammonitore – ma anche ammaliatore per la posizione in cui viene emesso – all’aumentare dei combustibili fossili nell’aria.
Nei premi qualche concessione alla semplificazione spettacolare però non viene negata. Così si spiega il Leone d’Oro alla concettuale spiaggia lituana e il totale oblio (anche da parte della critica) dello spettacolare ed enciclopedico padiglione cileno, monumentale rivisitazione e rovesciamento dello sguardo colonizzatore.

Alexander Sokurov

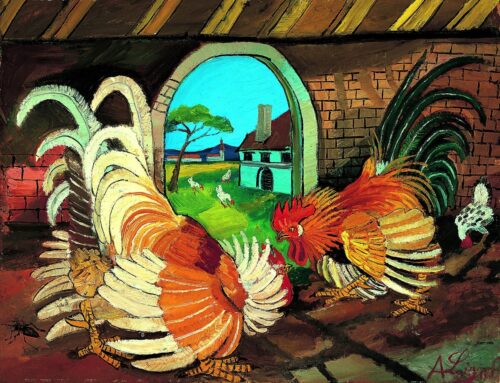




Scrivi un commento