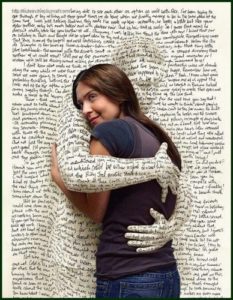
Tutti hanno già recensito “Eccomi” di Jonathan Safran Foer, quindi mi asterrò dal farlo. Mi concentrerò su un’altra questione: Foer (Safran Foer per gli amici, o almeno per la maggior parte dei recensori) insegna scrittura creativa alla Columbia University.Bene, immaginiamo che questo testo sia un modello per i suoi allievi. Cosa ne apprenderebbero?
Mio padre, che insegnava la scherma, avrebbe sostenuto, senza bisogno di leggerlo, che da Foer e dal suo romanzo sicuramente nessuno potrebbe imparare nulla sulla scrittura creativa.Era stato un bravo sciabolatore (mio padre, non Foer) ma non un campionissimo.E, diventato grande maestro di levatura internazionale, teorizzava che il suo passato di atleta medio ma non eccellente fosse stato essenziale nella buona riuscita didattica.Un fuoriclasse, sosteneva, il più delle volte ha delle doti eccezionali (nel riflesso, nella scelta di tempo, nel gesto atletico) che non è assolutamente in grado di spiegare. Il fuoriclasse di rado eleva la tecnica al grado massimo di ortodossia. Di solito la forza, e la viola in un modo tutto suo, ed è quella trasgressione a renderlo superiore (se ci pensate è quel che vale per la bellezza). “Come fa a insegnare quello là?” si accalorava riferendosi a uno di questi fuoriclasse “Cosa può dire all’allievo? Quando l’altro si muove toccalo” (toccare nella scherma sta per colpire l’avversario. E in effetti il fuoriclasse smise presto si allenare).
“Eccomi” è costruito sui dialoghi. Ce ne sono un’infinità: esilaranti, profondi, improbabili, geniali, crudeli, (in una scuola di scrittura di tendenza suggerirebbero di rendere il punto così: Ce ne sono un infinità. Esilaranti. Profondi. Improbabili. Geniali. Crudeli), irritanti, pre-hollywodiani, post-broadwayani, woodyalleniani, edificanti, infantili, paradigmatici, polifonici. (scusate se torno sul punto di prima. Non è che non ci stia bene il punto attaccato a ogni aggettivo, o a un’altra parola. E’ che adesso è diventato quasi, vogliamo dire… scolastico? Fatelo pure ogni tanto. Però non basta per diventare scrittori creativi. Tra l’altro, come dopo mostrerò, Foer usa persino il compianto punto e virgola).
C’è una cosa che accomuna questi dialoghi: sono formidabili. Rispondono a delle tecniche narrative ma le tendono sino a un centimetro dal punto di rottura, sempre e in qualsiasi registro, e li mescolano, i registri. Se Foer provasse a spiegarne la struttura li avvilirebbe, perché la struttura diventa quasi secondaria. Quei dialoghi sono un prodigioso incontro tra il parlato vero e il parlato letterario, tra il parlato che ci fa piacere ritrovare su un libro, poiché ci è familiare nella vita reale, e il parlato in cui ci fa piacere annegare in un libro, perché quello della vita reale ci ha rotto i coglioni (vita reale dixit). Forse, praticando un interminabile estrazione di matrioske, Foer potrebbe descrivere i suoi dialoghi con altri suoi dialoghi, che a loro volta…
Come mai parlano tanto bene i personaggi di Foer? Perché sono bravi a pensare, in primo luogo: anche quando agiscono impulsivamente o si fanno risucchiare dalla fobie e dalle piccolezze. Nel ritmo conversazionale di Foer la coerenza psicologica dei personaggi brilla nelle loro umanissime incoerenze.
Insomma, Foer si troverebbe, rispetto all’insegnamento dei dialoghi, nella tipica situazione: quando quello si muove toccalo. Potrebbe giusto dire scrivi i dialoghi come me. Niente di più.

Ma le scuole di scrittura creativa servono? Intanto, dipende dagli obiettivi. Per quelli funzionali, intendo extra-letterari, servono meravigliosamente (e sbaglia chi pensa che la creatività ben messa per iscritto serva soltanto a far letteratura). Per quelli artistici dipende dagli obiettivi, e anche dal talento. Ma non ha torto chi domanda perché si dia per scontato che i musicisti vadano al conservatorio, gli artisti all’accademia e si presenti come balzano che gli aspiranti scrittori frequentino una scuola di scrittura, o magari un precettore.
Come metterla però con i fuoriclasse? Sono abili all’insegnamento? Io non so come Foer sia in aula. Ma certo nel libro alcune forme di continuità stilistica sono trasparenti e, al contrario dei dialoghi, si prestano all’esempio e all’emulazione. Comprenderli non significa che si può realizzarli bene come Safran Foer (son così tante righe che ne tratto, e tante pagine che l’ho letto, che mi sento di rivolgermi a lui come se fossi suo amico, o suo recensore: ma mi domando perché con il secondo dei suoi nomi e il cognome, un po’ alla maniera di certi calciatori brasiliani?) ma sicuramente che si potrà scrivere meglio di quanto si facesse prima.
Su una tecnica in particolare voglio focalizzarmi. Consiste in una strana commistione tra la descrizione caratterizzante di un ambiente, di taglio balzachiano, condotta dal narratore esterno e il monologo interno; quasi un flusso di coscienza che il personaggio delega al narratore e che investe gli oggetti con un apparente disordine ribaltato in ordine quasi maniacale nel progressivo scavo della memoria. Pare che l’occhio veda tutto e ricrei il filo dei significati. In realtà l’occhio seleziona (secondo un processo del tutto rispondente ai meccanismi ordinari del cervello) tutto quanto è funzionale all’emergere della coscienza, una volta che l’inconscio abbia deciso di vuotare il sacco.
“Trovò il proprio cappotto, se lo mise. Le tasche erano piene: scontrini, un piccolo arsenale di caramelle per corrompere, e chiavi, e biglietti da visita, e monete straniere assortite per viaggi che ricordava di aver progettato e per cui ricordava di aver preparato i bagagli ma che non ricordava di avere fatto. Con due manciate trasferì tutto nella spazzatura, come tashlich.
Andò alla porta d’ingresso senza fermarsi: superando l’insalata di cavolo bianco, il caffè nero, il pesce azzurro, i blondies; superando le bibite viola e il liquore alla pesca; superando le chiacchiere sugli investimenti, su Israele, sul cancro. Superando il brusio del kaddish del lutto; superando uno specchio coperto da un lenzuolo nero; superando le foto di Isaac sul mobile: con gli israeliani l’ultima volta che erano venuti; al quarantesimo compleanno di Julia; sul suo divano, con lo sguardo perso. Quando arrivò alla porta notò, per la prima volta, il libro da firmare posato sul tavolino. Lo sfogliò per vedere se i suoi figli avessero scritto qualcosa.”
Siamo insomma oltre la cosiddetta narrazione in terza persona con il punto di vista limitato. Il narratore anticipa quello che il personaggio arriverà a interpretare oppure ha rimosso, non il pensiero preciso di quel momento, e nemmeno la pura sensazione.
Vediamo questo brano sulla sua casa, quando immagina di darne un resoconto para-dizionaristico (in questo caso è un teorico io narrante, perché viene riportata la sua fantasia mentale, ma articolata secondo l’oggettività ipotetica del narratore terzo):
“Casa Bloch, più bella della media, ma non la più bella. Però bella. Anche se non bella come potrebbe. Interni meditati, nei limiti della praticità. Alcuni bei mobili di modernariato, perlopiù comprati su Ebay o Etsy. Alcuni mobili IKEA rivisitati nel modo giusto (maniglie di cuoio, mobiletti sfaccettati). Fotografie appese a gruppi (equamente distribuiti tra le famiglie di Jacob e Julia). Farina di mandorle in un barattolo di vetro di Williams Sonoma su un ripiano di steatite. Una cocotte Le Creuset blu Marsiglia troppo bella per essere usata sul fornello retrostante di destra di una cucina doppia Lacanche il cui potenziale andava sprecato in ragù vegetariani. Alcuni libri erano stati comprati per essere letti (o almeno infilarci il naso); altri per dare l’impressione di una curiosità molto specifica da parte di una mente dagli interessi molto ampi; altri ancora, come l’dizione rilegata in due volumi dell’Uomo senza qualità, per la bellezza dei dorsi, supposte di idrocortisone acetato sotto una pila di New Yorker nel cassetto centrale del mobiletto dei medicinali. Un vibratore dentro a una scarpa su uno scaffale in alto. Libri sull’Olocausto dietro libri non sull’Olocausto. E su per lo stipite della porta della cucina, un diagramma di crescita dei figli di Bloch.”

Non si tratta di puri elenchi. Foer non è Perec che si sedeva al tavolino e archiviava analiticamente un luogo, senza troppo scalfire l’asciuttezza del dato materiale (naturalmente le distanze non sono mai così rigide: il riferimento ai libri comprati per questo o quell’altro scopo riecheggia vagamente un meraviglioso racconto di Perec sulla biblioteca ideale). Foer spezza la cosità degli oggetti, messi in fila in apparente oggettività, perché accenna o esplicita le ripercussioni che l’oggetto ha avuto con l’esistenza del soggetto, con il suo problema di apparire verso gli altri. Nelle descrizioni sopra, movimentate dalla turbolenza del personaggio che le rivive secondo il significato personale, leggiamo spesso non solo a cosa servono le cose ma anche a cosa non servono per quello specifico personaggio. Gli anomali elenchi di Foer/Safran Foer sono prospettive dalle quali abbozzare sia una biografia che una non-biografia. Le cose sono spesso più interessanti quando sono tracce di occasioni perdute. Quando le avevamo dimenticate e, ora che le scorriamo, sbattiamo contro l’epifania del perché le avevamo dimenticate.
Tale finalità consente a JSF di trattare allo stesso modo i ricordi e i desideri. Con uno schema di ripetizione e di accumulo, in cui la realtà e l’ipotesi, la memoria e la presenza si contendono lo spazio del discorso, rimandandosi l’una all’altra.
“Si immaginava una settimana da sola nel Big Sur. Magari al Post Ranch Inn, magari in una delle camere con vista sull’oceano. Magari un massaggio,magari facciale, magari un “trattamento” che non tratta niente. Magari avrebbe camminato in un tunnel che scavato nel tronco di una sequoia, gli anelli di accrescimento curvi attorno a lei.
Si immaginava di avere un cuoco personale. I vegani vivono più a lungo e sono più sani e hanno una pelle più bella e a lei non sarebbe dispiaciuto; sarebbe stato facile, se qualcuno avesse fatto la spesa, cucinato e pulito per lei.
Si immaginava che Mark notasse piccole cose di lei che lei non aveva mai notato di se stessa: un uso deliziosamente improprio di certe espressioni idiomatiche, che cosa fanno i suoi piedi mentre lei passa il filo interdentale, il suo buffo rapporto con il menu dei dolci.”
O anche:
“Jacob cercava di mantenere le conversazioni con Julia sottoterra, ma lei aveva bisogno che la fine della loro famiglia fosse vista e toccata. Esprimeva il suo immutato rispetto per Jacob, il suo desiderio che restassero amici, migliori amici, e con una buona cooperazione genitoriale, la migliore, e che facessero ricorso a un mediatore famigliare per non perdersi in tutto quello di cui non bisognava occuparsi e preoccuparsi e che vivessero vicini e andassero in vacanza insieme e ballassero insieme ai rispettivi secondi matrimoni, anche se lei giurava che non si sarebbe mai risposata. Jacob concordava, senza credere che nulla di quello che lei diceva stesse succedendo o sarebbe successo. Avevano vissuto così tanti passaggi necessari: gli addormentamenti dei bambini, le dentizioni, le cadute dalle prime biciclette, la fisioterapia di Sam. Anche questo probabilmente sarebbe passato.”

Il metodo che Foer ha scelto per esprimere il realismo, al di fuori dei dialoghi, è l’accumulazione (che poi in un modo differente ritorna anche nei dialoghi). Non solo in ogni descrizione di luogo, di evento, di stato interiore ci sono un sacco di cose ma queste cose non hanno uno statuto omogeneo. La scrittura di JSF coglie perfettamente, per dirla con Magritte, che questa non è una pipa. Che un oggetto non è mai solo un oggetto e che nell’accaduto rientra un pezzo di quel che non è accaduto. E che tanto più si riesce a dar conto della pluralità di strati tanto più il cervello percepisce un approccio familiare. E’ il realismo dell’accumulazione.
Come potrebbe Foer insegnarlo ai fini della scrittura? Immagino che dovrebbe invitare i suoi allievi a esplorare uno spazio, per un tempo limitato, e prendere velocemente appunti su quel che hanno visto. Poi invitarli a una seconda ricognizione, e prendere appunti su quanto era loro sfuggito. E poi chiedere di collegare quel che hanno visto a qualcosa che è loro accaduto e quel che non hanno visto a qualcosa che non era accaduto (ma poteva accadere). E poi provare a incrociare: legare eventi reali a oggetti omessi e eventi immaginati (o temuti oppure omessi) a oggetti che l’attenzione aveva selezionato.
E poi dire: fatta quest’operazione nello spazio proviamo a farla nel tempo. Prendiamo il 2013 e passiamoci dentro, come fosse una stanza. Cosa ricordiamo? Più attenzione adesso: cosa abbiamo cancellato? Scriviamo entrambe le aree. Che cosa le lega insieme?
Il risultato finale sarà realistico perché, anche quando non lo sappiamo, e così che viviamo nel mondo.
“Viviamo nel mondo, pensò Jacob. Quel pensiero sembrava sempre fare capolino, di solito contrapposto alla parola idealmente. Idealmente andremmo ogni fine settimana nei ricoveri per i senzatetto a preparare panini e impareremmo a suonare degli strumenti in tarda età e smetteremmo di pensare alla mezza età come a un’età tarda e faremmo uso di qualche risorsa mentale oltre a Google e di qualche risorsa fisica oltre ad Amazon ed elimineremmo in modo permanente la pasta ai formaggi e dedicheremmo almeno un quarto del tempo e dell’attenzione che meritano ai parenti che stanno invecchiando e non metteremmo mai un bambino di fronte allo schermo. Ma noi viviamo nel mondo e nel mondo ci sono gli allenatori di calcio e la logopedista e la spesa da fare e i compiti e mantenere un livello di pulizia accettabile in casa e i soldi e gli umori e la fatica e poi siamo solo essere umani e gli esseri umani non solo hanno bisogno ma meritano cose come un po’ di tempo con un caffè e un giornale, vedere gli amici e concedersi una pausa, quindi per quanto sia bella quell’idea, non c’è modo di realizzarla. Dovremmo, ma non possiamo.”

Dovere e non potere è precisamente vivere (male, magari) nel mondo: perché non è mai disgiunto vivere ciò che è reale dal non vivere ciò che è ideale, e dei due stati d’animo non è mai facile individuare quale sia la vittima e quale il carnefice. Non c’è miglior alibi di un gretto e vincolante reale per allontanare un ideale non veramente desiderato. Per questo accumuliamo pezzi di entrambi e li incorporiamo negli oggetti, negli eventi e nei pensieri. Questo (Safran) Foer lo ha capito benissimo.
Johnatan Safran Foer
Eccomi


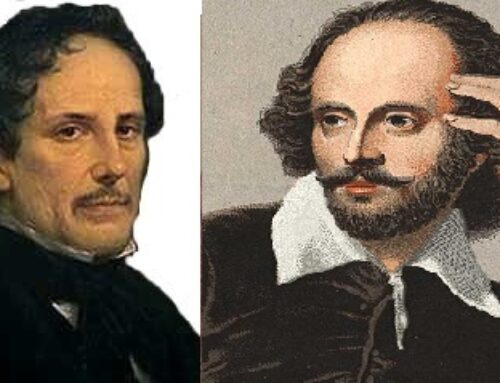



Scrivi un commento