Ufficio Visti

Biennale 2022, ci mancherai? Siamo all’ultimo week-end, e sorvolando sul fatto che la domanda è ovviamente retorica (per lo più la si vede una volta sola, e quel punto il desiderio è piuttosto proiettato verso la Biennale futura), la risposta, la mia almeno, è sì. È stata un’egregia Biennale, dal punto di vista della qualità delle opere e anche per le splendide mostre collaterali (Kiefer, Kapoor, Beuys, Dumas… ma pure Afro peccato per chi se lo è perso, e poi tante altre tracce meno mirabolanti, eppure stimolanti e a volte incantevoli, come un visionario video dell’artista di Hong Kong Angela Su, un finto docufilm vagamente imparentato con Zelig di Woody Allen).
Al fine di inquadrarla criticamente, focalizziamoci su tre punti: la selezione degli artisti, il tema scelto per l’edizione e il modo in cui è stato raccolto, sia in termini formali che di spirito.

Per quel che concerne la selezione, Beatrice Alemani ha compiuto una scelta, coraggiosa non dico nei principi (che anzi in questo momento sono piuttosto conformisti, specie per chi che come lei vive a New York) ma nella modalità: spazio alle donne, secondo un criterio di rivalsa e opposizione al maschile, e però nel metodo, semplice e franco. 190 su 213 partecipanti, infatti, erano di genere femminile o non binario. Una posizione radicale e intelligente, senza attardarsi in sterili redistribuzioni, che ha prodotto risultati estetici chiari (poi diremo quali), per quanto possa considerarsi non risolutiva rispetto al controllo, tuttora prevalentemente maschile e bianco, del filtro galleristico (insomma facilmente metabolizzabile dal mercato, e in questo senso non rivoluzionaria sino al midollo). Molto più felice e schietta questa scelta rispetto alla strada dell’indennizzo storico consistente nell’assegnazione a tutti i costi dei premi – che in questo momento domina molte manifestazioni culturali, e che pure in questa circostanza ha elargito in eccesso il Leone d’Oro al padiglione inglese celebrante, onestamente e con una certa eleganza, ma con pulsione creativa assai flebile, le cantanti nere del jazz (peraltro una delle rare eccezioni storiche al disconoscimento del ruolo femminile nell’arte). Al contrario, meritatissimo è stato il Leone d’Oro all’artista, appannaggio delle gigantesche sculture di Simon Leigh, che allestivano il padiglione statunitense: al centro dei suoi progetti è una visione della soggettività femminile afroamericana, di rado espressa con tanta potenza e puntuali contestualizzazioni storiche, con simile equilibrio tra seriosità, da un lato, e dall’altro colto parodismo dei fraintendimenti e delle estetizzazioni colonialistiche occidentali riguardo agli oggetti e alle condotte di mondi spirituali complessi presenti nella diaspora africana e nelle cerimonie rituali degli antenati (e, stilisticamente, con un’affascinante visione architettonica del corpo). Più in generale, la selezione degli artisti ha attinto a piene mani dall’Africa e dall’America latina ed evidenziato il già noto talento di Beatrice Alemani come curatrice.

Meno convincente l’esposizione del tema, intitolato Il latte dei sogni, e piuttosto ruffiana e superficiale nelle affermazioni della stessa curatrice. Lo spunto è tutt’altro che meschino, un racconto della scrittrice e illustratrice Leonora Carrington, e in astratto anche l’invito alle tre grandi aree tematiche – la rappresentazione dei corpi e le altre metamorfosi, la relazione tra gli individui e le tecnologie, il legame tra i corpi e la terra – ma esageratamente ideologizzato e irrigidito nella dichiarata pretesa di contrapporre “essere permeabili, ibridi e molteplici” all’idea “rinascimentale e illuminista dell’Uomo moderno, in particolare del soggetto maschile, bianco ed europeo come fulcro dell’immobile universo e misura di tutte le cose”, che storicamente schematizzato in questo modo è una traccia da scuola media, oltre che uno svarione colossale sul Rinascimento. Tanta insulsa generalizzazione, tuttavia, ha fatto sì che ciascuno si regolasse di testa sua, e che l’indicazione risultasse infine quella che scolasticamente si chiama la risposta a piacere. Per questo, in termini di contenuto, la Biennale mi è parsa più sfilacciata di altre edizioni, ma alla fine non è che ciò sia stato per forza un male: del resto al momento esistono davvero spinte centrifughe nelle tendenze, che a loro volta sono un segno di nuove ricerche di equilibri. Qualcuno ha lamentato che l’esito fosse un certo disimpegno: personalmente ne ho ricavato l’impressione contraria e la piacevole sensazione che le questioni che più ci affliggono siano state trattate a uno stadio più profondo e astratto. Insomma sono andate oltre l’angustia culturale del tema che, nella sua declinazione, avrebbe meritato maggiori coordinate spaziotemporali. Se mettiamo al centro la metamorfosi, e neppure per accidente facciamo menzione di Ovidio, siamo davvero appiattiti sul presente. E pensare che Ovidio affidò al genere femminile l’onere audace di trasgredire le regole di un mondo e sopra-mondo convenzionati a misura di un maschile, chiaramente rappresentato come oppressivo.
Dal punto di vista formale, ha dominato il neosurrealismo antropomorfico, che ha segnato un potente ritorno dei dipinti e della figurazione. Molte installazioni, anche, poche fotografie (troppo poche francamente rispetto alla vivacità del panorama mondiale contemporaneo), pochi video (ma uno multiplo sensazionale di cui dirò fra poco) e soprattutto zeru tituli (cfr. Mourinho old style), cioè niente NFT e in generale notevole diffidenza verso l’arte digitale. Arriviamo così a indicare due marchi di questa Biennale, che sospetto essere gli sbocchi della selezione di genere attuata dalla curatrice (o dal signor curatore, direbbe il nostro neo-presidente del consiglio). Primo: grande materialità, appunto in contrapposizione all’evaporume della digital art. Secondo: via quei musi lunghi! Nelle ultime Biennali essere impegnati significava, con una certa regolarità, essere cupi, distopici, depressivi e all’occorrenza necrofili. Da queste parti tutt’altra luce, molta ironia e un approccio più ottimisticamente costruttivo alle questioni sociali.

Opere belle da conservare nella memoria tante, e ognuno ritaglierà le sue. Personalmente ho provato un debole per Francis Alys e il suo padiglione del Belgio (che ben sarebbe stato meritevole di un riconoscimento): una sala costellata di schermi proiettanti cortometraggi dedicati ai giochi dei bambini nel mondo, quella speciale capacità infantile di crearli dal nulla, le loro costanti universali, le infinite varianze, un panorama emozionante che va dal fanciullo congolese che si trastulla ruotando un copertone ai bordi di una miniera all’inseguimento dentro una casa abbandonata in Messico (non è lo stesso effetto che esserne assalito da tutti assieme, ma chi lo desidera può guardarseli su Internet). Il lavoro artigianalmente più sbalorditivo mi è parso quello di Malgorzata Mirga-Nas, che nel padiglione polacco ha sovrapposto sui simboli del ferrarese e rinascimentale Palazzo Schifanoia scene di rappresentazione della cultura rom. Sempre nel campo dei padiglioni, tra quelli meno scontati nelle aspettative, mi piace ricordare quello maltese, nel quale gocce di acciaio fuso cadono dall’alto in sette vasche piene d’acqua, ognuna delle quali rappresenta metaforicamente un soggetto della pala d’altare caravaggesca La decollazione di San Giovanni Battista. E la bella notizia è che, dopo un po’ di cilecche, quest’anno il padiglione italiano affidato a Gian Maria Tosatti, con Storia della notte e Destino delle comete, ha fatto un figurone (non ricordo dove ho letto la sua più bella definizione, un “monumentale ready-made civile e metafisico”): un attraversamento di fabbriche dismesse fortemente e commovente immersivo, con riferimenti alle “lucciole” pasoliniane. E fuori dai padiglioni, dove non meno di quaranta artisti meriterebbero di essere raccontati nel dettaglio, menziono almeno la pittura di denuncia dell’afroamericano Noah Davis; i dipinti su tele svolazzanti di Emma Talbot, che salta da uno stile graphic novel a uno orientaleggiante in mezzo a testi calligrafici che insieme fondono le esperienze personali e interiori dell’artista con una variegata cosmologia; l’abbagliante pittura archetipica e di influenza precolombiana di Gabriel Chaile. E su tutto la scatenata fantasia della cilena Cecilia Vicuna, Leone d’Oro alla carriera per la seconda volta, “eco-femminista” che agisce da tramite espressivo di misconosciuti universi spirituali indigeni.
Corrado Augias, Il Venerdì
Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore
La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio
Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:
-
Hai detto male di me
-
Hai violato un confine
-
Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto


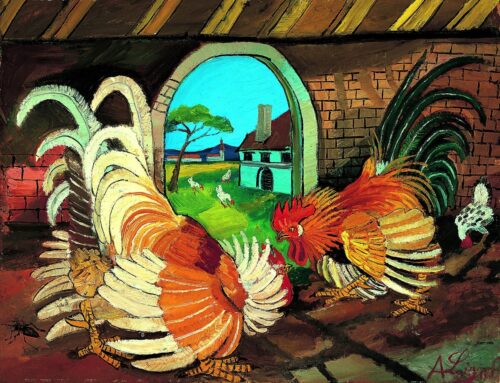




Scrivi un commento