Estratto (da “Derelitti e delle pene”)

Le prigioni repubblicane. Il carcere della vergogna
Per fronteggiare l’emergenza degli italiani prigionieri di guerra in Italia, nel 1945 si allestirono, a fianco delle carceri ordinarie, delle prigioni supplementari, di solito consistenti in campi all’aperto. Il più tristemente famoso era a Coltano, in una frazione di Pisa: una piana polverosa che con la pioggia si trasformava in un paludoso e fetido acquitrino nel quale, per sette mesi, trentacinquemila persone furono alloggiate in tende canadesi. Anche se teoricamente era destinato a internare gli sconfitti, ci finirono dentro 3500 partigiani che non riuscivano a comprovare la propria posizione e molti ragazzi che si erano trovati addosso la divisa della Repubblica sociale per caso o necessità. Il 31 ottobre il campo venne smantellato e solo pochi prigionieri dirottati nelle carceri ordinarie nelle quali, peraltro, gli ex partigiani stavano diventando inquilini abituali assai più degli ex fascisti. Alla fine del 1946, a Bologna erano detenuti 321 comunisti, 84 simpatizzanti dello stesso partito, 18 socialisti e 3 fascisti. A Reggio Emilia 197 militanti di sinistra convivevano con sei democristiani, un disertore americano e un unico fascista.
Quanto la criminalità comune, nel 1946 essa toccò vette mai sfiorate in precedenza. Nella capitale, ad esempio, si registrò un incremento dei furti pari al 527 % mentre l’aumento nazionale delle rapine si attestò sul 265%.
Il fatto è che, dopo la ferocia nazifascista, ma anche le purghe partigiane e la Realpolitik degli alleati e delle prime misure postbelliche, il valore della legalità era una delle tante fumanti macerie che desolavano il paesaggio nazionale e non esisteva più autorità morale in grado di spendere efficacia persuasiva nella prevenzione dei delitti. La guerra, lo abbiamo visto, aveva fatto dell’abuso della forza e delle morti violente un elemento abituale della quotidianità. Altre condizioni favorirono la diffusione della criminalità: la disponibilità di armi belliche, lo scompaginamento sociale seguito alla crisi economica, rovinosa per alcune famiglie. O talvolta anche dettagli apparentemente ininfluenti: così, ad esempio, a Milano, il fatto che delle 25.000 lampadine che assicuravano l’illuminazione pubblica ne funzionassero solo 7.000, assicurando ai malfattori il gradito conforto dell’oscurità.
Il risultato fu una grave crisi materiale dell’istituzione carceraria che si trovava, tra politici e comuni, a gestire negli anni 45-46 un sovraffollamento eccezionale, per giunta all’interno di un ulteriore indebolimento del già fragile apparato edilizio, avendo alcune case di pena riportato danni ad opera dei bombardamenti. Il numero di reclusi al 31 dicembre del 1946 superò le 60.000 unità, e il computo complessivo delle entrate lievitò attorno alle 250.000.
Fame, condizioni igieniche, miraggio delle amnistie, odio politico di parti contrapposte, sbracamento della vigilanza, sbrigativi metodi di punizione: questo era il palcoscenico carcerario nel biennio 45-46, e da esso germinarono continue rivolte. A Regina Coeli, già nell’occhio del ciclone per la voce che bastasse pagare per essere cortesemente accompagnati al portone d’uscita, nell’estate del 1945 i detenuti tentarono di incendiare l’edificio. A Venezia, a settembre, trecento reclusi si barricarono dentro la prigione, stanati da un lancio di bombe a mano che cagionò due morti. Ad Alghero, a novembre, una sommossa costò la vita ad alcune guardie. Alle Nuove di Torino si trascorsero festività natalizie agitate. Il 26 dicembre i 1500 detenuti abbandonano le loro celle, le cui serrature sono quasi tutte rotte, e provano a forzare in massa i cancelli, respinti dal fuoco, prevalentemente intimidatorio, delle forze dell’ordine. Tra coloro che intervengono ad arringarli sulla scorrettezza della condotta c’è anche il sindaco i cui richiami deontologici, tuttavia, stridono con il suo passato di evaso. L’incontro tra le autorità e una delegazione, che espone la richiesta di provvedimenti che snelliscano i lunghi tempi di attesa processuali, pare pacificare gli animi, anche se per prudenza i detenuti vengono lasciati da soli nell’istituto, al punto che nominano un direttivo per amministrarsi. Nella serata successiva alcuni di loro accedono all’impianto di illuminazione e tolgono la luce al fabbricato, circostanza che viene sfruttata in modo diverso, secondo l’indole e le impellenze. Alcuni si introducono, ben accolti, nel reparto femminile; altri accedono ai depositi a fare razzia, specie di tabacco, e verranno per questo chiusi nelle celle di rigore dagli stessi compagni; altri sperimentano la fuga, provocando nuove raffiche di mitra dagli agenti che circondano la prigione. Il 28, allo spargersi della voce che come assaggio di ritorsione non verrà distribuito il rancio, tornano a dirigersi in massa verso le vie di uscita e quasi accoppano gli elementi partigiani che sino ad allora avevano proficuamente svolto opera di moderazione. Questa volta la reazione della polizia è decisa e risospinge gli insorti nelle celle. Gli agenti rimangono a presidiare i corridoi con l’ordine di sparare a vista a chi soltanto si sporga dallo spioncino sino a che i capi dell’agitazione non vengono condotti in un altro istituto.
La rivolta con la piega più drammatica si svolge a Milano, nella Pasqua del 1946. 800 detenuti di San Vittore sequestrano venticinque ostaggi e si barricano all’interno. Si dice che siano forniti di armi fino all’inverosimile, che abbiano scovato sotto terra un arsenale abbandonato dai tedeschi, che dispongano persino del «pugno tedesco», un maneggevole e micidiale cannoncino la cui sagoma minacciosa qualcuno ha intravisto vicino a una finestra. Inizialmente, la loro unica condizione è la liberazione di tutti i detenuti; diversamente minacciano di resistere sino alla morte ma dopo avere prima fatto penzolare i cadaveri degli ostaggi. Il fatto che a capo dell’ammutinamento si insedino elementi di estrazione fascista come l’ex gerarca Caradonna e il famoso bandito Ezio Barbieri (che aveva militato nella Muti ma in realtà era un personaggio piuttosto indipendente) aliena subito agli insorti le simpatie dei comunisti, che chiedono una brutale repressione al ministro Togliatti e, per voce de l’Unità, adombrano il sospetto che dietro la ribellione si celi una manovra politica volta a influenzare i lavori della costituente. In realtà, anche in quel caso, la principale spinta all’azione (magari astutamente incanalata dai più spregiudicati) proveniva dalle indecenti condizioni dei ristretti, 3500 in spazi pensati per neppure la metà e in attesa di processi che non si sapeva minimamente quando si sarebbero svolti. Ufficiale di polizia, tenuto in ostaggio, appena liberato commenta: «Vivono nell’inferno. Bisogna capirli e compatirli di conseguenza». Dopo inutili trattative, nel corso delle quali i detenuti affievoliscono le loro richieste, e due giorni di sparatorie, che costeranno complessivamente la vita a tre agenti e cinque detenuti, irrompono in vero assetto di guerra i militari della Folgore che si aprono la strada facendo saltare un muro con una mina, coperti dal fuoco dell’artiglieria pesante che parte da tutti gli angoli del muro di cinta. I rivoltosi, che non hanno toccato un solo ostaggio, si arrendono. La loro dotazione di armi si rivela essere un bluff, anche quello che era stato individuato come «pugno tedesco» era solo un manico di scopa. Processati per direttissima scontano pene pesanti: le più dure sono i 24 anni inflitti a Barbieri e i 30 a un altro delinquente comune, Regonini. La sua dichiarazione attesta che solo nella compattezza della disperazione i detenuti avevano cementato un’intesa che inizialmente era segnata da profonde divisioni: «Sono io che ho voluto la sommossa perché l’esistenza a San Vittore era diventata insopportabile. Ai fascisti tutti i privilegi: mangiavano polli, bevevano cognac, erano pieni di denaro, si intontivano di cocaina. A noi la pagnotta nera e la sbobba». Tutti i rivoltosi vengono trasferiti. Sarebbe, oltre che una misura di sicurezza, anche una punizione: ma certo per gli altri duemila non è un premio restare perché la parziale inagibilità dell’edificio li costringe a dormire diverse notti per terra in cortile.
Negli stessi giorni i detenuti si impadroniscono del carcere di Modena e, prima di essere piegati, nominano un loro stato maggiore e dichiarano di non riconoscere più l’autorità dei giudici.

Un libro in tre parti, diverse ma complementari. La prima, la pena pensata, risponde alla domanda “perché punire” e si confronta con le ipocrisie sottese all’attuale sistema. La pena applicata, traccia una minuziosa storia della prigione in Italia, con il supporto di materiali d’archivio, e oscilla spesso tra il drammatico e il grottesco. L’ultima parte, la pena vissuta, è una collezione di brevi monologhi, raccolti dall’autore sulla base di colloqui effettuati nei più importanti istituti di pena del paese: più che resoconto una narrazione, condotta sul filo di una tensione linguistica che mira a restituire nello stile la frammentazione e l’isolamento delle voci ascoltate.





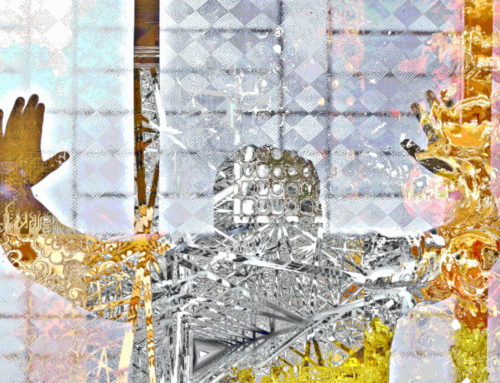

Scrivi un commento