Estratto (da “Derelitti e delle pene”)

Nel caos che travolge le carceri nell’immediato dopoguerra, la prima preoccupazione del governo diventa quella di riprendere in mano la situazione. Così, le circolari tra il 1945 e il 1948, si soffermano sulla necessità di un ritorno alla disciplina e alla normalità e indugiano esclusivamente su indennità, vestiario e appalti. Eppure, considerato che ci troviamo di fronte a un non insignificante cambio di regime politico, ci si aspetterebbe di ritrovare anche uno spiraglio di luce, e genericamente un esplicitato intento di discontinuità. Al contrario, sembra di scorgere in quell’asciuttezza retorica il confinamento esclusivo della questione in una dimensione burocratico-organizzativa che nulla lascia presagire di buono per il progredire dell’istituzione penitenziaria. Non è un caso se nessun imbarazzo o riluttanza trapela in una circolare del 21 agosto 1945 che, prendendo atto della circostanza che «alcuni custodi o altri incaricati del servizio di mantenimento detenuti nelle carceri mandamentali hanno richiesto e pretendono la corresponsione di compensi esagerati» dispone che «ove s’incontrino gravi difficoltà per la confezione e somministrazione del vitto al detenuto in due volte al giorno […] senz’altro il vitto venga continuato a somministrarsi in una sola volta al giorno».
Nemmeno per gli agenti di custodia tirava aria di grandi innovazioni. Un decreto immediatamente successivo alla liberazione aveva invero formalizzato il loro inquadramento militare, determinando un miglioramento della retribuzione, ma anche un irrigidimento della già asfissiante sottomissione disciplinare. Restava in vigore il regolamento del 1937 (a sua volta ampiamente ripetitivo di quello precedente del 1891) che non si contentava di prevedere 72 infrazioni sanzionabili in cui l’agente poteva incappare (compreso «accomunarsi a mangiare e bere con detenuti liberati da meno di tre anni») ma stabiliva anche, garantendolo persino meno del detenuto, che egli potesse essere punito in modo adeguato «alla gravità della mancanza commessa» anche per mancanze non previste da nessuna norma. Rimaneva inalterata, soprattutto, la funzione meramente repressiva e custodiale. Il maggior prestigio attribuito dalla divisa militare aveva risvolti modesti e talora contraddittori: secondo l’articolo 33 del citato decreto, «gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l’obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma». I rapporti coi funzionari erano mortificanti. A Torino nel 1946 il capoposto scrive al direttore del carcere: «Signor Direttore. Giusto ordine S.V. Ill.ma elevo rapporto a carico dell’agente perché si è permesso di fermare in portineria S.V. Ill.ma dicendo che i carabinieri alla porta si lamentavano che hanno freddo». Viene allegata la giustificazione dell’incolpato: «Non credevo di mancargli di rispetto a S.V. Ill.ma fermandolo a riferirgli quanto i carabinieri mi avevano pregato di fargli conoscere». Il comandante aggiunge: «Promette di non farlo più». L’agente se la cava con una diffida.
In un discorso parlamentare del 27 ottobre 1948, Piero Calamandrei, arringando contro le condizioni delle carceri, disse che «bisogna esserci stati per rendersene conto». Lui personalmente, puntualizzò, non aveva avuto questo «onore»: ma molti militanti si; ed effettivamente la loro esperienza poteva fungere da base, cognitiva ed emozionale, per superare la visione tradizionale della prigione, così come era stata tramandata sin dall’epoca liberale. Ma gli azionisti erano già minoranza nel paese. Nella seduta parlamentare di due giorni dopo, Calamandrei chiese di nominare una commissione d’inchiesta sul modo in cui venivano estorte le confessioni agli arrestati, sulle condizioni dei detenuti e su come gli agenti di custodia ne ottenessero l’obbedienza. Il ministro della giustizia Grassi lo pregò di non insistere, promettendo che il governo avrebbe accolto quest’indicazione come una raccomandazione. L’onorevole Tambroní propose una mediazione, cassando dall’ordine del giorno il riferimento alle pressioni della polizia sugli accusati e sostituendo la commissione d’inchiesta ad hoc con una commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo sull’andamento delle carceri. Era evidentemente l’offerta di una pietra tombale sul passato in cambio del potere di incidere sul futuro: e su questo Grassi accettò di transigere (per la parte espunta, con sconcertante sincerità, rilevando conclusivamente: «non potevo consentire che venisse fatta un’inchiesta contro la mia amministrazione»). I risultati della commissione, nonostante la prestigiosa composizione della medesima, saranno piuttosto modesti, livellati dall’accortezza nel non addentrarsi mai nella denuncia dei singoli disservizi.
Tutto sommato è sorprendente che, anche nell’opinione pubblica, se non un moto d’indignazione, neppure un sussulto di fastidio si sia rivolto verso la crudezza della dimensione carceraria. I primi anni quaranta, infatti, avevano fatto della prigionia un’esperienza quasi generalizzata, poiché essa era toccata in sorte ad almeno un componente di un buon numero di famiglie. Qui non ci riferiamo al carcere in senso stretto, ma a campi di lavoro, di prigionia militare, di concentramento. Certo, la perdita della libertà era maturata per ragioni diverse dalla commissione di un crimine, eticamente inoppugnabili; o almeno neutre, quando era stata causata solo dal trovarsi in un certo luogo o nell’appartenere a una data razza. Ma, giustificata o meno che sia, la privazione della libertà ha sempre un unico colore, sapore, odore. E che l’avessero patita o temuta in tanti poteva indurre a un atteggiamento generalmente più mite nei confronti di qualsiasi forma di reclusione. Così non fu, né deve trarre in inganno il contenuto programmatico dell’articolo 27 della Costituzione, che esalta l’aspetto rieducativo della pena, ma che si risolse in un vezzo culturale e, nella realtà dei fatti, in un modo per mantenere spoglia la giornata dei detenuti, mutilandola di tutto ciò che non avesse diretta finalità emendativa. La condizione psicologica prediletta dalla generazione che aveva assistito o partecipato alla guerra era la rimozione. Probabilmente fu così anche per il carcere, attorno al quale non si avverti il pulsare di una sensibilità che pure poteva essere particolarmente ricettiva. Venne anzi considerata una componente di rassicurante ritorno alla normalità ripristinare l’alterità antropologica dei detenuti, classificarli nel segno di una distanza di classe facilmente individuabile, e colpirli, con il consenso di un’ampia base sociale, con una vera conventio ad excludendum sul piano dei diritti civili.
La condizione dei carcerati, rispetto all’epoca fascista, peggiorò sicuramente in termini relativi: nel senso che se sotto una dittatura è immaginabile che nei confronti dei detenuti non vengano usati troppi riguardi, in una democrazia ci si attenderebbe che alcuni minimi, normativi ed esistenziali, spettino in capo a ciascun individuo, indipendentemente dal fatto che egli risieda in un carcere. Ma non è azzardato dire che essa peggiorò anche in termini assoluti: una dittatura, quando deve comportarsi da dittatura, è a casa sua; non ha particolari problemi a nascondere gli atti di forza quando li commette (e anzi gode a ostentarli) e non ha remore né inesperienza nel gestirli. Una democrazia, al contrario, è in grande imbarazzo quando deve violare la legalità che è alla radice della sua stessa legittimità e ragion d’essere: nasconde i fatti, è pasticciona, resa incoerente dalla spinta di forze contrapposte. E la sua violenza non è quella pianificata e razionale della dittatura ma quella isterica e sproporzionata del neofita. Una violenza che si sarebbe connotata sul piano della repressione fisica ma anche dell’inflizione di inutili e ridicoli ascetismi e di sottili torture psicologiche.

Un libro in tre parti, diverse ma complementari. La prima, la pena pensata, risponde alla domanda “perché punire” e si confronta con le ipocrisie sottese all’attuale sistema. La pena applicata, traccia una minuziosa storia della prigione in Italia, con il supporto di materiali d’archivio, e oscilla spesso tra il drammatico e il grottesco. L’ultima parte, la pena vissuta, è una collezione di brevi monologhi, raccolti dall’autore sulla base di colloqui effettuati nei più importanti istituti di pena del paese: più che resoconto una narrazione, condotta sul filo di una tensione linguistica che mira a restituire nello stile la frammentazione e l’isolamento delle voci ascoltate.





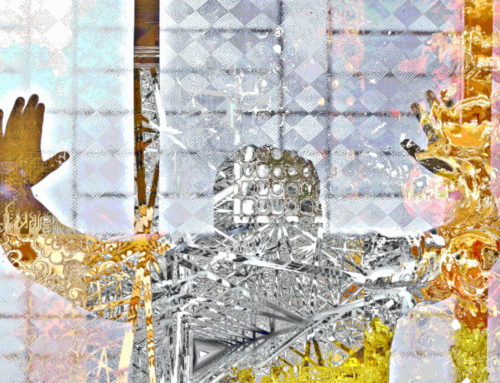

Scrivi un commento